Commento Consiglio di Stato sez. IV - 21:08:2024, n. 7192
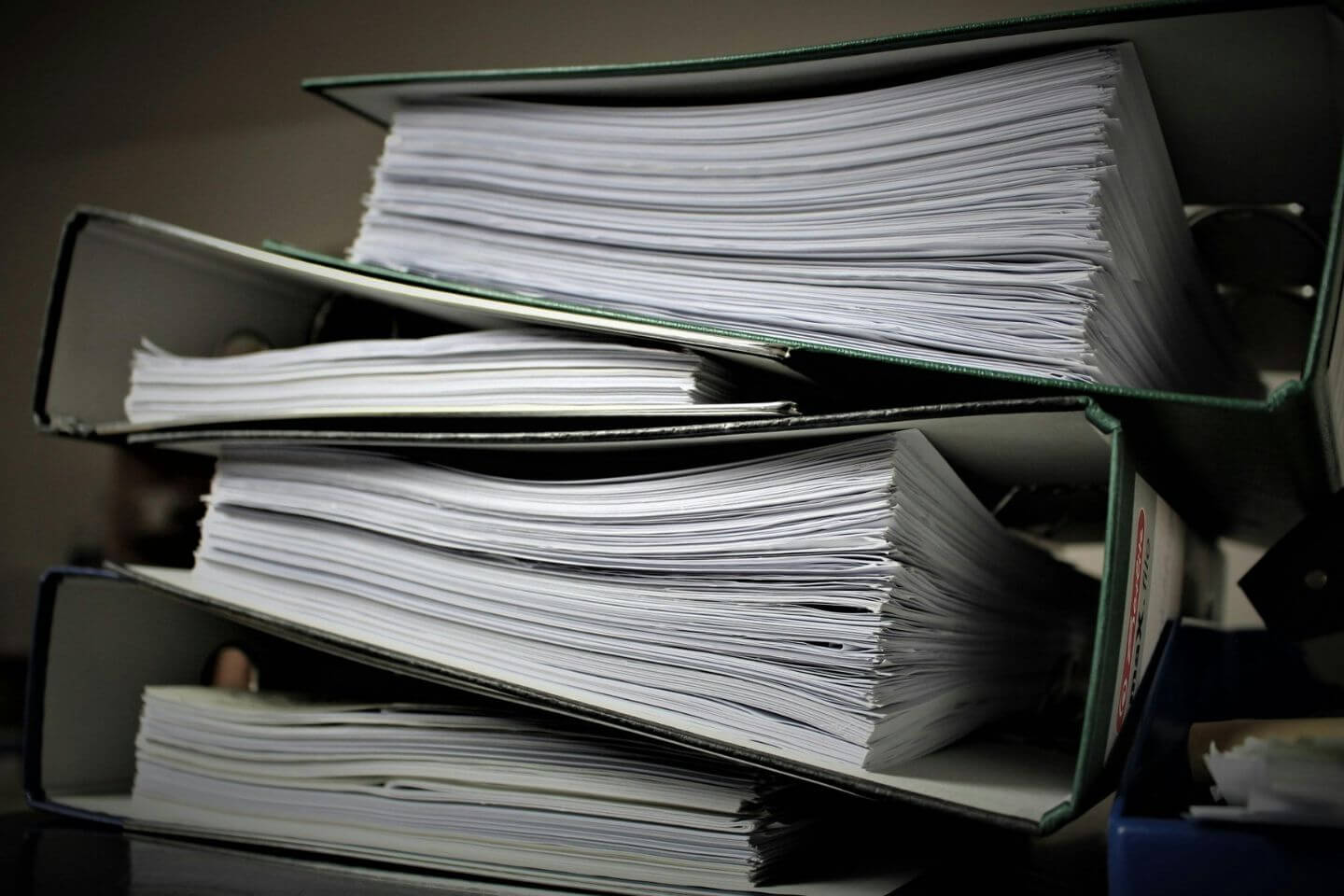
Commento dell'Avv. Elena Berto
La società appellante impugnava la sentenza n. 96 del 2023, del TAR Toscana, con la quale era stato respinto il ricorso, dalla medesima società proposto, per l’annullamento della determinazione comunale n. 668 del 2021, recante il “diniego di rilascio di un permesso di ricerca ”, giusta artt. 8 e ss. della Legge Regione Toscana n. 38 del 2004, recante “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali ”, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con D.P.G.R. Toscana, n. 11 del 2009.
Il T.A.R. adito, senza pronunciarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dal Comune, respingeva il ricorso ritenendolo infondato nel merito.
Avverso tale pronuncia, veniva proposto appello, formulando tre distinte censure.
Si costituiva in giudizio il Comune, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello. Il Comune, inoltre, riproponeva le eccezioni preliminari che erano state sollevate nel primo grado di giudizio e, tra queste, l’eccezione di “improcedibilità” del ricorso introduttivo, per mancata notifica, ad almeno un controinteressato.
All’udienza pubblica del 13 giugno 2024, il Collegio rilevava un possibile profilo di rimessione al giudice di primo grado, giusta art. 105, comma 1, c.p.a., per omessa integrazione del contraddittorio, nei confronti di taluni controinteressati , i quali, pur non avendo espresso, concretamente, una manifesta opposizione, sarebbero stati, comunque, coinvolti dall’attività in questione.
Tuttavia, in ragione della mancata presenza delle parti in udienza (a causa del fatto che le stesse avevano, del tutto legittimamente, chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione) non è stato possibile sottoporre la questione al contraddittorio nel corso dell’udienza pubblica.
Il Collegio, pertanto, con l’ordinanza n. 5401 del 2024, assegnava il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o, comunicazione, in via amministrativa, dell’ordinanza medesima, per il deposito di memorie.
Entrambe le parti, nel rispetto dell’anzidetto termine, depositavano memorie in relazione ai profili rilavati d’ufficio dal Collegio.
All’esito del deposito delle anzidette memorie, il Collegio reputava che la sentenza del T.A.R. dovesse essere annullata per violazione dell’art. 105, comma 1, c.p.a., per omessa integrazione del contraddittorio, nei confronti dei soggetti controinteressati.
Siffatta disposizione prescrive che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del giudizio. Sicché le parti sono tenute a riassumere il processo, con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell’ordinanza.
Conseguentemente, in conformità all’art. 49 c.p.a., il giudizio di primo grado avrebbe dovuto svolgersi a “contraddittorio integro”, per garantire il “giusto processo” e “l’effettività della tutela giurisdizionale”, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, oltre che per assicurare il rispetto dei principi di (i) economia processuale, (ii) concentrazione dei giudizi, (iii) simultaneità del processo e (iv) uniformità di giudizio.
Devesi, infatti, tenere presente che, altrimenti, sarebbe configurabile, per i “terzi pretermessi”, la possibilità di proporre il rimedio “dell’opposizione di terzo”.
Sicché, il Collegio, considerato che è mancato il pieno contraddittorio, nei sensi sopra chiariti, e che è stato violato l’art. 49 c.p.a., ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 105, comma 1 del c.p.a., per la rimessione della causa al giudice di primo grado, previo annullamento della sentenza impugnata, come di consueto si dispone in fattispecie simili (Cfr Cons. Stato, Sez. VI, 28 novembre 2022, n. 10427).
Ad avviso del Collegio, la configurabilità di controinteressati deve essere riconosciuta, anzitutto, tenuto conto del carattere “invasivo” dell’attività di ricerca di cui si discute, che si estrinseca nell’esecuzione di un’attività materiale nell’ambito della proprietà altrui, con l’evidente conseguenza che si tratta di operazioni che il proprietario, in assenza della concessione del permesso di ricerca, avrebbe la facoltà di impedire, nell’esercizio dello ius excludendi alios desumibile direttamente dalla nozione civilistica del diritto di proprietà prevista dall’art. 832 c.c.
In ogni caso, anche a prescindere dai principi sopra richiamati, la configurabilità di soggetti controinteressati sarebbe, direttamente, confermata anche dall’art. 13 del D.P.G.R. del 24 marzo n. 11/R, secondo cui: “i soggetti controinteressati possono proporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio ai sensi del comma 1, eventuali osservazioni ed opposizioni all'istanza di permesso di ricerca ”.
Ne consegue che la presenza di controinteressati, nel caso di specie, è riconosciuta, direttamente, sul piano normativo.
Sotto un diverso profilo, non sarebbe condivisibile la tesi dell’appellante secondo cui i proprietari dei terreni rientranti nell’area di ricerca avrebbero manifestato la loro opposizione solo in relazione all’attività di ricerca e non anche rispetto al rilascio del permesso. In primo luogo, infatti, la distinzione risulta eccessivamente formalistica e comunque irrilevante, ove si consideri che la posizione di controinteressato va valutata sul piano sostanziale, con l’ovvia conseguenza che l’opposizione di cui si tratta esprime senza dubbio la contrarietà dei predetti soggetti rispetto alla compressione della loro sfera giuridica, compressione che, come già osservato, deriva anzitutto, su un piano logico e cronologico, dalla concessione del permesso di ricerca, prima ancora che dall’attività materiale. In secondo luogo, per questa medesima ragione, è, evidente, che l’opposizione all’esecuzione dell’attività di ricerca implica, nuovamente, sul piano strettamente logico, che vi sia opposizione anche al rilascio del permesso, poiché l’ipotesi contraria sarebbe contraddittoria.
Da ultimo, è manifestamente irrilevante l’argomentazione prospettata dall’appellante per il cui tramite è stato evidenziato che, se fosse riconosciuta la posizione di controinteressati ai soggetti sopra richiamati, la società “ avrebbe dovuto notificare il ricorso introduttivo del presente giudizio a tutti i proprietari dei terreni rientranti nell’area interessata dal progetto di ricerca, con un ampliamento indiscriminato del numero dei litisconsorti necessari, lesivo del suo diritto di difesa”.
Tale argomentazione è, del tutto, ininfluente, dal momento che, in primo luogo, attiene a un profilo non già di diritto, bensì di mero fatto, correlato al numero, meramente casuale, di proprietari presenti nell’area di ricerca, che, astrattamente, potrebbe anche essere particolarmente esiguo. In secondo luogo, peraltro, si tratta di un profilo superabile mediante la notifica per pubblici proclami, rispetto alla quale, comunque, ogni valutazione è rimessa esclusivamente al T.A.R.
In base alle considerazioni rese oggetto di rappresentazione, dunque, i proprietari di terreni siti nell’ambito dell’area di ricerca per la quale è stato chiesto il permesso, sono stati considerati alla stregua di controinteressati.
In proposito, giovi tenere in debita considerazione che, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’individuazione dei controinteressati richiede un elemento formale e un elemento sostanziale; cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4609, secondo cui: “la qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o, comunque, agevolmente individuabili, in base ad esso, (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto impugnato in quanto quest’ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale)” .
Con riferimento al requisito formale è appena il caso di rilevare che, nella specie, i predetti soggetti erano agevolmente individuabili poiché tutte le osservazioni dai medesimi presentate erano state comunicate dal Comune all’appellante con la nota del 25 novembre 2021, depositata dal Comune medesimo.
Del resto, la conferma dell’agevole individuabilità dei predetti soggetti si desume in modo univoco anche dalla circostanza che la società ha, effettivamente, notificato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ad uno dei signori che rientrava nel novero di quei soggetti, con la conseguenza che non solo essi erano agevolmente individuabili, ma sono stati, altresì, effettivamente, individuati.
Per quanto riguarda, invece, il requisito sostanziale, è stato sufficiente richiamare le considerazioni sopra prospettate a proposito del carattere invasivo di un’attività che i proprietari avrebbero avuto titolo per impedire sulla base del loro ius excludendi alios. Inoltre, è risultato conferente anche il richiamo di quanto osservato a proposito dell’espressa qualificazione in termini di controinteressati desumibile dall’art. 13 del D.P.G.R. del 24 marzo 2009, n.11/R, e, ancora, l’opposizione dei proprietari dei terreni siti nell’area di ricerca, manifestata attraverso le comunicazioni poi trasmesse dal Comune all’odierna appellante.
