Corte appello sez. III - Napoli, 25:06:2024, n. 7388
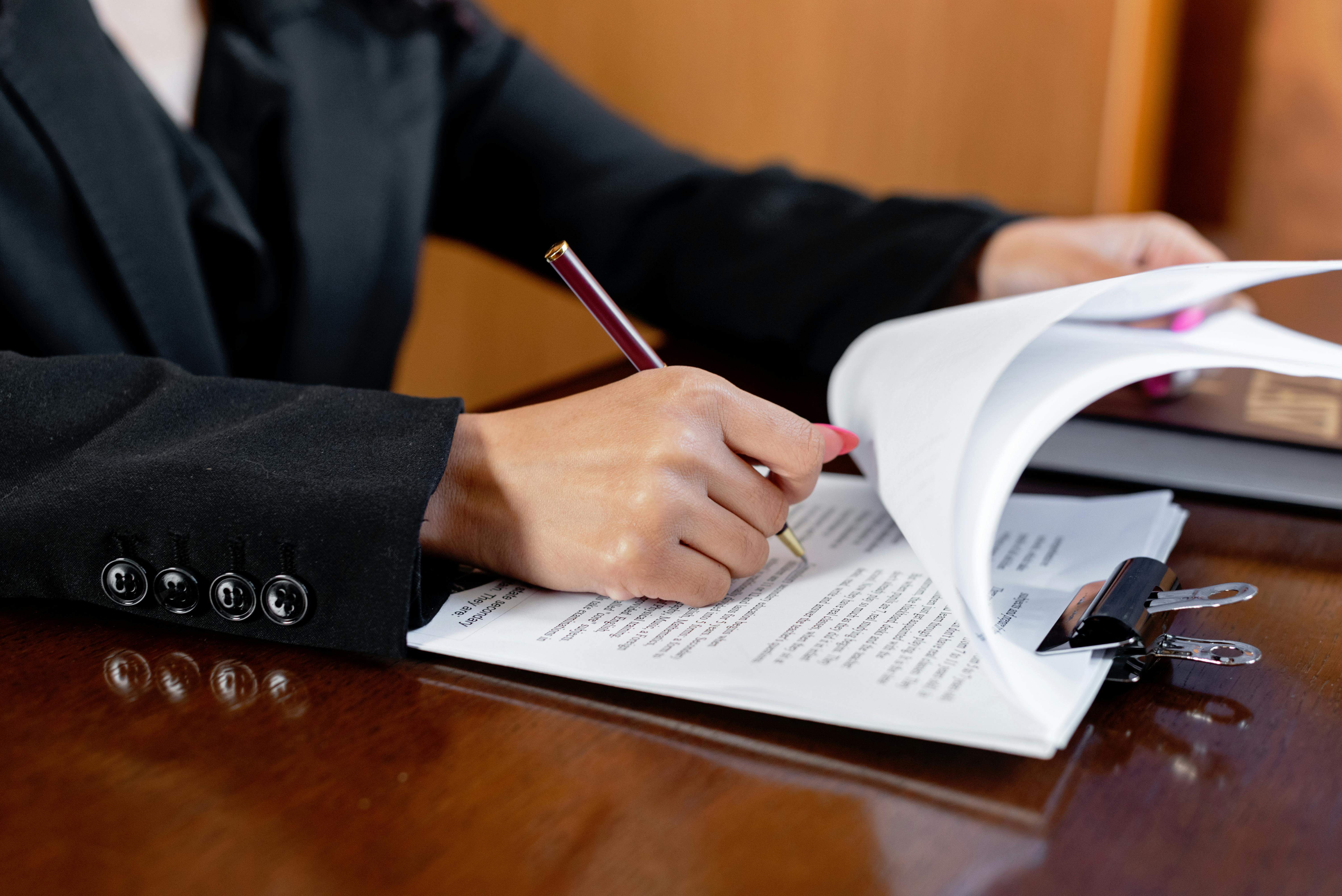
Commento dell'Avv. Elena Berto
Con sentenza, emessa in data 31 marzo 2022, dal Tribunale di Nola, in composizione monocratica, l’imputata, all’esito di giudizio abbreviato, veniva giudicata colpevole del reato di cui all’art. 640 bis cp, considerandosi, in esso, assorbito, il reato di cui all’art. 7, primo comma, del D.L. n. 4 del 2019, convertito in Legge 26 del 2019.
Il convincimento del primo giudice1 si fondava sugli esiti dell’istruttoria investigativa, dalla cui disamina si evinceva che l’imputata, con istanza avente protocollo n. (…) del 15 aprile 2019, avesse beneficiato, a far data dal mese di maggio 2019, e per tutta la durata prevista dei 18 mesi, di prestazioni economiche erogate dall’INPS, sezione Reddito di Cittadinanza, in difetto del requisito di “ possedere un valor del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000,00 ”.
L’imputata, a mezzo del suo difensore, proponeva rituale appello avverso la sentenza di primo grado , impugnandola nella sua totalità, in particolare, chiedendo: (i) l’assoluzione perché il fatto non sussiste, ex art. 530 comma 1 cpp, ovvero perché non è provata la sua penale responsabilità ex art. 530, comma 2 cpp; (ii) dichiararsi la nullità della sentenza per omessa valutazione della memoria difensiva depositata all’udienza del 31 marzo 2022; (iii) riconoscersi la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cp; (iv) revoca della confisca di quanto in sequestro.
La sentenza impugnata veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli .
Con il primo motivo di gravame 2 , la difesa contestava la valutazione del primo giudice nel ritenere che la semplice omissione dichiarativa, quale elemento oggettivo del reato di cui all’art. 7 D.L. 4 del 2019, fosse da sussumere nell’alveo del diverso elemento richiesto per l’integrazione della (ben più grave) fattispecie del reato di cui all’art. 640 bis cp.
La sentenza di prime cure si criticava anche per via della “duplice sussunzione”, della condotta di omissione dichiarativa, oltreché ai fini (i) dell’integrazione dell’elemento oggettivo degli artifici e raggiri, altresì, per sostenere (ii) l’integrazione dell’elemento soggettivo del dolo generico richiesto dall’art. 640 bis cp.
Inoltre, secondo la difesa, il basso grado di istruzione dell’imputata, già di per sé, sarebbe risultato bastevole per ammettere il deficit valutativo in ordine alla compresione del tenore della norma.
Orbene, le citate deduzioni difensive sono apparse prive di pregio, ritenendosi, al contrario, che la sentenza appellata fosse frutto di un corretto ragionamento logico-giuridico; da doversi, come tale, intendere, integralmente, richiamata.
Ed invero, la motivazione per relatione è consentita, con riferimento alla pronuncia di primo grado, laddove le censure formulate contro di quest’ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; giacché il giudice di appello non è tenuto a riesaminare, dettagliatamente, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte ed esenti da vizi logici.
Nondimeno, in sede di gravame, è apparso d’uopo precisare che i rilievi difensivi non abbiano colto nel segno in quanto del tutto avulsi dall’insegnamento reso evidente dell’evoluzione giurisprudenziale, in ordine al rapporto che intercorre tra la fattispecie di legge speciale, giusta art.7 del D.L. 4 del 2019, e quella di cui all’art. 640 bis cp, oltre che tra quest’ultima e l’ipotesi di cui all’art. 316 ter c.p.
Sicché, nel caso di specie, si è ritienuto che il P.M, nel formulare l’imputazione, abbia individuato, correttamente, il reato più grave, nel delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 640 bis cp, in luogo del reato di cui all’art. 316 ter cp.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 27 aprile 2007, n. 1658, il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è in rapporto di sussidiarietà, e non di specialità, con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con la conseguenza che il primo reato è configurabile soltanto laddove difettino, nella condotta, gli estremi del secondo.
La Suprema Corte, pertanto, individua il discrimen tra i delitti in parola proprio nella c.d. induzione in errore, presente nella truffa e mancante nel delitto di cui all’art. 316 ter cp3 .
Con la diretta conseguenza che, laddove, come nel caso dì specie, l’obbligo di dire la verità è, non solo sancito dalla legge, ma, altresì, presidiato da un’apposita figura di reato, l’omissione di informazione dovute, di cui all’art. 7 comma 1 legge cit., deve essere inquadrata nell’ambito degli “artifizi e raggiri” che integrano il reato di cui all’art. 640 bis cp.
In particolare, l’idoneità della condotta alla “induzione in errore” è risultata, nel caso di specie, configurabile sotto il duplice profilo, oggettivo e soggettivo.
In primo luogo, sotto il “profilo oggettivo”, la condotta ingannevole, nella misura in cui risulta determinate ai fini dell’erogazione, appare senza dubbio tale da procurare una falsa rappresentazione dei fatti in chi deve provvedere, vale a dire il soggetto erogatore, che ripone affidamento solo sull’autocertificazione dell’istante, poiché non tenuto ad alcun accertamento.
Detto soggetto erogatore, nientemeno, finisce per ritenere dovuto il beneficio, proprio sull’erroneo presupposto che le informazioni offerte, all’atto della richiesta, siano veritiere, ancorché, in concreto, l’istante non abbia alcun diritto.
Dal punto di vista “soggettivo”, di poi, l’induzione in errore dell’ente pubblico erogatore costituisce il “fuoco del dolo” del privato, posto nell’ottica di voler ottenere un beneficio, che per la reale situazione patrimoniale in cui versa, non gli spetterebbe; di guisa ché, a tale scopo, giustappunto, decide di raggirare la Pubblica Amministrazione, attraverso una rappresentazione difforme della propria realtà patrimoniale, che induce, pertanto, a ritenerlo idoneo alla elargizione dell’utilità.
Gioco forza, ne consegue che nella ‘fraudolenza’ della condotta de qua , che pervade anche il dolo del soggetto agente, siano ricorsi gli artifici e i raggiri, che hanno indotto in errore la P.A., ai fini dell’ottenimento di un ingiusto profitto, tale da configurare la fattispecie più grave di cui all’art. 640 bis cp.
Siffatto assunto è vero e non altrimenti discutibile, atteso che, come già precisato dalla Suprema Corte, “una dichiarazione attestante una consistenza patrimoniale diversa da quella reale, perfeziona gli artefici e raggiri, in modo da indurre in errore la P.A., tenuto conto che l’ingiusto profitto è rappresentato dalla riscossione dell’emolumento ” (Cassazione penale, Sez. II, Sent n. 2402 del 20.01.2021).
La Corte, in particolare, ci tiene a rimarcare come la dichiarazione di una “consistenza immobiliare”, diversa da quella reale, integri – quale condotta violatrice degli obblighi di lealtà sottesi alla disciplina del reddito di cittadinanza – gli “artifici e raggiri”; ed è tale da indurre in errore la Pubblica amministrazione. A suffragare la rilevanza penale della condotta, di poi, vi è anche l’atteggiamento “elusivo e non trasparente”, il quale impedisce la concessione del reddito di cittadinanza, di talché esso è da qualificare come “ingiusto profitto”, quand’anche l’autore della condotta presenterebbe i requisiti reddituali per ottenere il beneficio.
Per tali ragioni, laddove, come nel caso di specie, dalla mancata indicazione della consistenza del patrimonio immobiliare sia derivato un profitto ingiusto, per il truffatore, e un danno patrimoniale, per lo Stato, si potrà ritenere sussistente il reato di truffa ex art. 640 bis cp.
Qualora, al contrario, dall’omissione dell’informazione dovuta, il richiedente il RDC non avesse conseguito alcun profitto, si sarebbe potuto ritenere, astrattamente, configurato soltanto il reato di cui all’art. 7, comma 1, Legge cit., che prescinde dalla presenza di tale elemento.
Tutto ciò posto, i giudici di seconde cure evidenziano la correttezza del ragionamento del primo giudice, a mente del quale, stante la clausola di sussidiarietà espressa prevista dall’art. 7, comma 1, L. cit., tra il reato descritto dalla norma in parola e il reato di cui all’art. 640 bis cp, non si configura un concorso formale di reati, bensì si è in presenza di un concorso apparente di norme, regolato dal principio di sussidiarietà; in forza del quale, quando una medesima situazione, di fatto, presenta, in apparenza, tutti gli elementi costitutivi di più fattispecie incriminatrici, si applica quella il cui interesse si presenta come più importante, o comprensivo di ogni altro interesse tutelato dalle norme convergenti, salvo, in caso di incertezze sulla gerarchia dei beni tutelati, dover applicare la norma che sancisce il trattamento più grave.
È stata ritenuta sussistente, dunque, nel caso in esame, la fattispecie di cui all’art. 640 bis cp, in essa assorbita la fattispecie di cui all’art. 7 del DL 4 del 2019, atteso che il comportamento omissivo del richiedente ha permesso all’intero nucleo familiare di percepire un benefìcio non dovuto, per tramite dell’induzione in errore dell’ente erogatore.
1 In particolare, dagli accertamenti eseguiti risultava “l’omissione dichiarativa” nella D.S.U. (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE), presentata a corredo dell’istanza del reddito di cittadinanza, in data 08/04/2019, dei dati relativi agli immobili posseduti in Italia, aventi “quota di rendita” pari al 1000/3000, (33 per cento), per un valore corrispondente ad un totale di euro 63.019,39; e, quindi, superiore a quanto consentito dall’art. 2, c. 1 lett. b) n.2 del D.L n.4/2019, che sancisce un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso della casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000,00. Inoltre, l’imputata ometteva di indicare il predetto patrimonio immobiliare nell’attestazione ISEE, alla voce “patrimonio immobiliare del nucleo” e di presentare la dichiarazione dei redditi, relativamente all’annualità oggetto del controllo, come poteva evincersi dal sistema informativo collegato all’Anagrafe Tributaria.
2 Con il secondo motivo la difesa eccepisce la nullità della sentenza per omessa valutazione della memoria difensiva, e, quindi, per carenza motivazionale, avendo il giudice di primo grado omesso di considerare, del tutto, le conclusioni formulate dallo scrivente difensore, all’udienza del 31 marzo 2022, benché rette dalle produzioni documentali effettuate ai sensi dell’art. 419 cpp; influendo, siffatta mancata valutazione, sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza oggetto del presente gravame. Il presente motivo di doglianza appare destituito di fondamento, atteso che – secondo orientamento consolidtao – devesi considerare esclusa l’automatica rilevanza della omessa valutazione di memorie quale causa di nullità.
3 Ne consegue che, ciascuna della condotte descritte nell’art. 316 ter cp, (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità o le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti, non per scelta soggettiva, ma in ragione del carattere giuridicamente fide-facente degli atti o documenti ad essi destinati, siano tenuti a fare sugli stessi affidamento. Ciò che rileva, dunque, non è tanto la definizione dei concetti di “artifizi” o “raggiri”, in cui sono ricomprese anche le condotte omissive, contrariamente a quanto deduce la difesa, bensì l’idoneità della condotta a determinare l’induzione in errore del soggetto, a cui consegue l’effettiva indebita percezione dell’emolumento.
